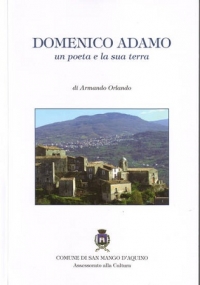|
|
|
Scarica il PDF |
|
Sono venuto a conoscenza dell’esistenza di Domenico Adamo nel mese di ottobre del 1966, quand’ero studente di Ragioneria e frequentavo con gli amici la bottega di vino di Ciccio Marsico ed Alessandro Berardelli, a San Mango d’Aquino.Nel cassetto di un vecchio armadio che fungeva da bancone Gino Marsico, figlio di uno dei proprietari e membro della comitiva, trovò allora un libretto di poche pagine, ingiallito dal tempo, e sulla copertina c’era scritto: “Domenichino Adamo – Musa bruzia – Brooklyn, N.Y. – 1932” - Lo aprii e lessi la prima poesia: “Cara Zampugna”. Da allora la curiosità per Domenico Adamo non ebbe più fine, ed il mio interesse fu infinito. Rovistando nell’Archivio dello Stato Civile del Comune riuscii a recuperare il registro che conteneva l’atto di nascita. Venni a sapere che cento anno or sono, ed esattamente il 5 settembre del 1888, alle ore 8:20 pomeridiane, nella casa di via Arella nasceva, da Francesca Tomaino e da Giuseppe Adamo, muratore di anni 28, un bambino al quale veniva dato il nome di Domenico. La mattina dopo il bambino venne dichiarato all’anagrafe, testimoni Saverio Notarianni, contadino, e Virgilio Torchia, barbiere; Ufficiale di Stato Civile Alfonso Maria Angotti. Il vecchio registro comunale, pieno di polvere ed abbandonato in mezzo a tante carte ingiallite, riportava un’altra annotazione: sposato il 3-12-1910 con Ferraro Francesca di Tommaso e di De Cicco Domenica; morto nel 1964 in America. Questo è tutto ciò che di Domenico Adamo riuscii a sapere al Municipio. Ma la ricerca continuò altrove. Accompagnato da Giacinto Trunzo, che assieme agli altri della comitiva frequentava quella che noi scherzosamente chiamavamo “bettola”, mi rivolsi ad Annibale Berardelli, una mitica figura di emigrato che in America aveva ricoperto incarichi di prestigio nella polizia federale e nella carriera diplomatica e che, una volta collocato in pensione, era venuto a trascorrere gli ultimi anni della sua vita nel paese natio. Annibale Berardelli mi fornì notizie essenziali sulla vita di Domenico Adamo, e mi parlò anche della bottega di sarto che il poeta aveva avviato a Brooklyn e che era diventata luogo di ritrovo e punto di riferimento per molti artisti emigrati. Da questa prima raccolta di notizie si è sviluppato un lavoro che è stato costante negli anni e che mi ha portato ad avere, oggi, un quadro completo della vita del poeta. Dopo alcuni incontri con Emilio Frangella, direttore di “Calabria Letteraria”, il quale fu per un certo periodo in corrispondenza con Domenico Adamo, ebbi altri contatti con gente emigrata; qualcuno mi parlò del figlio di Francesca “a zoppa” perché nel paese aveva letto le lettere del poeta alla vecchia madre, mentre Antonio Chieffallo, emigrato residente a Cleveland, nell’Ohio, mi spedì un fascicolo contenente diverse poesie. Infine, dopo vari tentativi, ecco l’incontro determinante con alcuni membri della famiglia di Domenico Adamo: Adelina, la figlia più piccola nata in America e sposata con un professore del New Jersey, e Beatrice, la figlia più grande rimasta sempre in Italia. A loro ho consegnato copia di tutto ciò che avevo scritto su Domenico Adamo: un articolo pubblicato a Nicastro nel 1966 sul giornale degli Scouts; un articolo del 1975 ed uno del 1980 pubblicati su “Calabria Letteraria”; un opuscono di 18 pagine ciclostilato in proprio nel 1982 e diffuso in cento copie; ed infine una copia del primo libro di storia, folklore, tradizioni e posia di San Mango d’Aquino, scritto nel 1977 con Antonio Sposato e contenente anche alcune poesie del padre. Le figlie di Adamo si mostrarono sorprese per l’attenzione e l’interesse suscitati, e recatesi a visitare la casa paterna, a San Mango d’Aquino, notarono anche il fatto che molta gente ricordava ancora il poeta e lo chiamava Domenichino, il diminutivo che affettuosamente gli avevano dato parenti ed amici. Gli incontri con Adelina e Beatrice mi hanno dato, così, la possibilità di conoscere meglio il poeta: personaggio timido e modesto, mite e gioviale, schivo e solitario, con animo oscillante tra il ricordo e la speranza. Egli visse sempre lontano da mondo della cultura ufficiale, e preferì passare il tempo dedicato all’arte insieme con pittori, poeti e narratori che si raccoglievano nel chiuso della sua bottega di sarto, lungo i viali di Brooklyn, oppure si ritrovavano in casa di amici e nei ristoranti per le cene conviviali. Riservato al massimo, preferiva nascondere persino il giorno della nascita per non festeggiarne la ricorrenza: “Noi con lui non siamo mai riuscite a conoscere il giorno esatto del suo compleanno”, hanno dichiarato a questo proposito le figlie. Non partecipò mai a concorsi letterari, eppure nel 1959 un’associazione con sede in Belgio gli assegnò una medaglia d’onore per elevati meriti sociali. Adelina dopo l’incontro avuto in Calabria mi scrisse una lettera dall’America dove – fra l’altro – così si espresse: “…Papà parlava spesso della sua terra natia. Quando ho letto il libro su San Mango l’ho fatto anche per lui, perché so che l’avrebbe goduto molto…”. Parole che confermano quanto amore Domenico Adamo ha avuto nel cuore per la sua terra d’origine. Un amore che gli ha dato la forza di sperare fino alla fine in un nuovo viaggio in Calabria, dove non tornava da più di 40 anni; ma questo viaggio non ebbe luogo, perché il poeta una sera non tornò più a casa. Lo cercarono per molte ore, nella bottega e per le strade, ma lo ritrovarono in un letto d’ospedale, in coma, vittima di un incidente stradale; dal momento dell’investimento non aveva più ripreso conoscenza, e qualche giorno dopo Domenico Adamo morì. Era il 10 marzo 1964. Sono passati più di vent’anni da quando ho letto la sua prima poesia, ed oggi ho chiara nella mente tutta la sua vicenda umana e poetica; una vicenda racchiusa tra i luoghi dell’infanzia, le idee giovanili, l’incomprensione dei contemporanei, gli ideali della maturità, il desiderio di cambiamento, la partenza per l’America, il lavoro, una buona posizione economica, la famiglia, e poi ancora la depressione di Wall Street del 1929, la tenacia, il ricominciare daccapo, la nascita dei figli, i ricordi, la nostalgia, la bottega con le tendine abbassate e lui dentro che scriveva o dipingeva, gli incontri con gli altri artisti emigrati… Attimi di vita, episodi, sentimenti, circostanze comuni ad una schiera innumerevole di uomini e di donne costretti a scegliere la via dell’emigrazione per dare un senso ed uno scopo alla propria vita. Nel periodo che va dal 1880 al 1924 più di 4 milioni e mezzo di italiani varcarono i confini degli Stati Uniti, e più tardi altri ancora partirono verso i paesi europei, il Canada, l’Australia. Dalla Calabria partono ancora oggi e gli emigrati, in massima parte giovani, si portano dentro la speranza di una vita migliore. In molte parti del mondo questi emigrati, per mantenere il legame con la propria terra, sono riusciti a creare un “altro” paese, simile per dialetto, per costumi e per tradizioni a quello lasciato; un paese doppio, un paese sosia, dove l’emigrato che non riesce a vivere lontano – ha scritto Vito Teti – torna con il pensiero al paese, vive il paese come sua ombra perduta, abbandonata o venduta. Perché gli emigrati hanno bisogno di un punto di partenza da non dimenticare – aggiunge Franco bartucci – e se essi uccidessero il paese ucciderebbero se stessi, così, in questi paesi doppi, l’emigrato in un certo senso non è mai partito, ma rimane sempre nel luogo di origine. Molti centri della Calabria hanno in America i loro paesi doppi; lo stesso luogo di origine di Domenico Adamo, per esempio, ha sviluppato attorno alla “San Mango d’Aquino Society” di Scranton, in Pensilvania, un sodalizio di grande importanza, mentre altre associazioni vanno nascendo (ultima, in ordine di tempo, quella di Winnipeg) ed intere vie di Montreal, Toronto, Cleveland, Sault Ste Marie sono occupate da famiglie di emigrati provenienti dallo stesso paese. Ed è qui che la comunità degli emigrati cerca di ricostruire l’ambiente lasciato in Italia. “Come è commovente vederli raccogliersi sotto le bandiere dei maggiori da loro venerati – ha scritto Guido Cimino a proposito dei lavoratori italiani all’estero – lo si è visto quando si è spento l’astro di Michele Pane, e creare le loro riviste, fatte alla buona, con molto cameratismo, ma sempre con molta intelligenza, per dare al minuto popolo d’Italia che vive sotto altro cielo “la Parola” della cultura, o il “Compasso” per la misura delle proprie e delle altrui forze, o la civetteria di una bella edizione che faccia colpo anche sui letterati rimasti al paese a sbarcare faticosamente il loro lunario…”. Sensi di solidarietà e di fratellanza, brandelli di umanità che sono rimasti vivi fra le comunità di emigrati e che resistono all’incalzare del tempo, come mi ha confermato recentemente Giovanni Chieffallo, giovane emigrato calabrese in Canada, socio fondatore e poi presidente dell’Associazione “Calabresi nel mondo”, un sodalizio che ha tenuto a Montreal la sua prima assemblea di fondazione nel 1983. Sentite come Francesco Greco, uno dei più noti poeti italo-americani, ha ricordato in un suo scritto l’incontro con Domenico Adamo:“Andavo di tanto in tanto a far visita ad Eugenio Adamo che risiedeva a Read Bank nel New Jersey; vi andavo in compagnia di Riccardo Cordiferro ed altri amici specie d’estate, per godere le bellezze di quel meraviglioso paesaggio e della superba spiaggia di Long Beach, ritrovo aristocratico molto vicino a Read Bank. Passavamo bellissime ore, parlavamo dell’Arte, di sogni e della nostra cara e tanto amata Calabria. Il caro Eugenio – ora da anni passato a miglior vita – mi disse di avere un cugino a Brooklyn, non molto lontano da dove abitavo io, e mi diede il suo indirizzo. Fu così che incontrai Domenico Adamo…”. Il nostro paeta, dopo il suo primo viaggio in Italia, aveva ripreso a scrivere, ispirato forse dai canti di Michele Pane ed incoraggiato dai giornali locali come “La verità”, “Il progresso italo-americano”, “Scrittori Calabresi”, “La follia di New York”; era così entrato nel mondo vasto ed affascinante degli artisti italiani all’estero, ed aveva fatto la conoscenza di numerosi poeti, scrittori, musicisti, i quali erano soliti riunirsi e dar vita ai loro famosi incontri conviviali al Leone Restaurant, nella quarantottesima strada di New York City. Uno di questi giornali, “La follia di New York”, era stato fondato da Alessandro Sisca, calabrese nato nel 1875 ed emigrato in America nel 1892, autore della canzone “Core ‘ngrato”, scritta in dialetto napoletano con lo pseudonimo di Riccardo Cordiferro. E’ a lui, a Riccardo Cordiferro che tante volte aveva inserito le sue poesie nell’angolo dei poeti ritagliato sul giornale, invitandolo a continuare a cantare sempre “come l’usignolo che canta nell’ombra per rallegrare la sua solitudine”, è a lui che Domenico Adamo dedicherà, in memoria, la lirica “Qual fulgente stella”, definendo il Sisca “guida che ci ammaestra e ci affratella verso la meta dell’umanità”. E dopo la pubblicazione delle liriche su riviste e giornali, dopo l’uscita dell’antologia di Spataro e dopo le due edizioni di Musa Bruzia, la vicenda umana di Domenico Adamo continua; nell’animo del poeta ritornano i ricordi, e con i ricordi ritorna travolgente la nostalgia. Ma all’improvviso ecco la morte porre fine alla sua avventura terrena. Il 5 settembre 1988 ricorre il centenario della nascita di Domenico Adamo, ed io, che mi ero assunto l’impegno di curare un lavoro dedicato interamente e lui per colmare una lacuna della letteratura calabrese e per rendere onore ad un figlio della nostra terra tanto coraggioso quanto dimenticato, posso dire di aver svolto, con questo libro, il mio compito. Ora la parola passa agli altri: agli studiosi della letteratura per illustrarne le opere e la poesia, ed alle autorità civili ed amministrative per ricordare una vita ricca di valori e di dignità. Armando Orlando San Mango d’Aquino, novembre 1987.
|